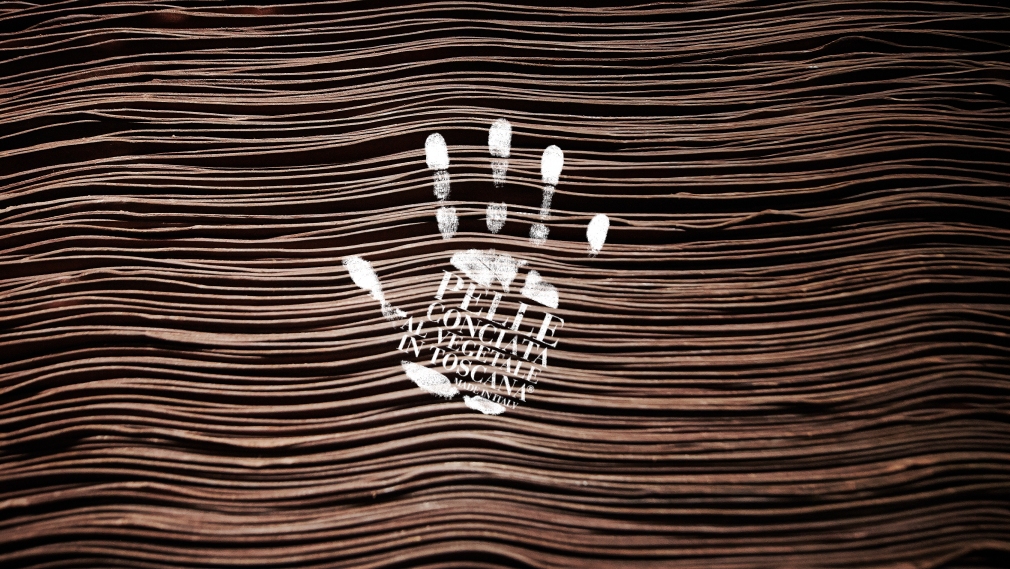Un luogo che non esiste più, almeno sulla carta, ma che continua a vivere e portare con sé ricordi, sofferenza e dolore. Ovvero quelli dei ricoverati che all’interno dell’Ex Manicomio di Volterra hanno trascorso parte della loro vita. Una struttura ampia, adibita ad ospitare fino a 6000 “malati”, ma che oggi vive nel degrado, incastonata all’interno di una cornice di alberi che creano un’atmosfera surreale. Il tempo, dentro al Manicomio di Volterra, sembra essersi fermato al 1978, anno di chiusura, ma le pareti, le finestre e le scritte lasciate ovunque raccontano ancora molto. Parlano di vite rinchiuse, di persone incomprese, di sentimenti schiacciati sotto il peso della vile etichetta di “matto”.
Il Manicomio di Volterra come un “villaggio”
Il Manicomio di Volterra negli anni era diventato noto per curare gli internati in un modo del tutto innovativo. Il responsabile più famoso della struttura è stato Luigi Scabia, l’ideatore del manicomio come “villaggio” per malati. Un progetto che portava gli ospiti del Manicomio a riacquisire, per quanto possibile, una dignità e a riconquistare un piccolo spazio nel mondo sociale attraverso il lavoro e la fatica.
Sentirsi persone li avrebbe riabilitati e avrebbe dato loro sollievo, mentre sentirsi chiusi, isolati dal mondo non avrebbe fatto altro che peggiorare la loro situazione. Gli internati dunque potevano lavorare all’interno della lavanderia, della fornace, della serra, della piccola azienda agricola oppure della macelleria presenti nella struttura: in questo modo tornavano a sentirsi importanti e la struttura ne beneficiava in termini economici, visto che una parte della produzione veniva poi venduta.
Una semplice segnalazione e la vita cambiava
Per essere internati e definiti “matti” dalla società purtroppo bastava poco, anche alcuni motivi estremamente banali: si narra che una famiglia di pastori sardi non eruditi fu internata per una settimana solo per la loro difficoltà nel farsi capire dagli altri. Parlavano soltanto il loro dialetto stretto, non erano pazzi. Un’altra donna, sempre secondo racconti d’archivio, fu rinchiusa qui dentro per essere diventata gelosa dopo aver scoperto i vari tradimenti del marito. Insomma, delle motivazioni che stridono fortemente con l’obiettivo per cui era nata la struttura.
Bastava una semplice segnalazione e la vita veniva stravolta per sempre: entrare in un Manicomio, indossare la divisa del “matto” segnava un solco profondo nell’esistenza delle persone. Esiste un prima e un dopo. In pochi giorni si passava da una vita normale a una da reietto, da emarginato. E a volte senza capirne realmente il motivo.
Un gesto folle in mezzo alla follia
Incidere un muro lungo più di 180 metri e alto più di 2 con la fibbia del panciotto non è altro che un gesto folle in mezzo alla follia, un modo per essere ricordato. Nel presente e nel futuro. Ed è proprio questo che ha fatto Oreste Nannetti, ribattezzato “Nof4“, negli anni in cui ha vissuto all’interno del Manicomio di Volterra. Storie, storielle ed eventi raccontati ed incisi come fosse un libro. Un “libro” particolare, frutto di solitudine, negazione e abbandono, ma che definisce il mondo visto con gli occhi di un internato o, come si era autodefinito Nannetti, di un “astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale“.
Perché molti internati avevano dei problemi anche seri, ma altri erano lì quasi per sbaglio. E c’è una frase, ritrovata nei carteggi del Manicomio, che descrive e racconta il tutto alla perfezione: “Qui dentro il 10% di noi muore per scosse elettromagnetiche indotte. Il 40% per cure sbagliate. Ed il 50% per carenza d’affetto“.